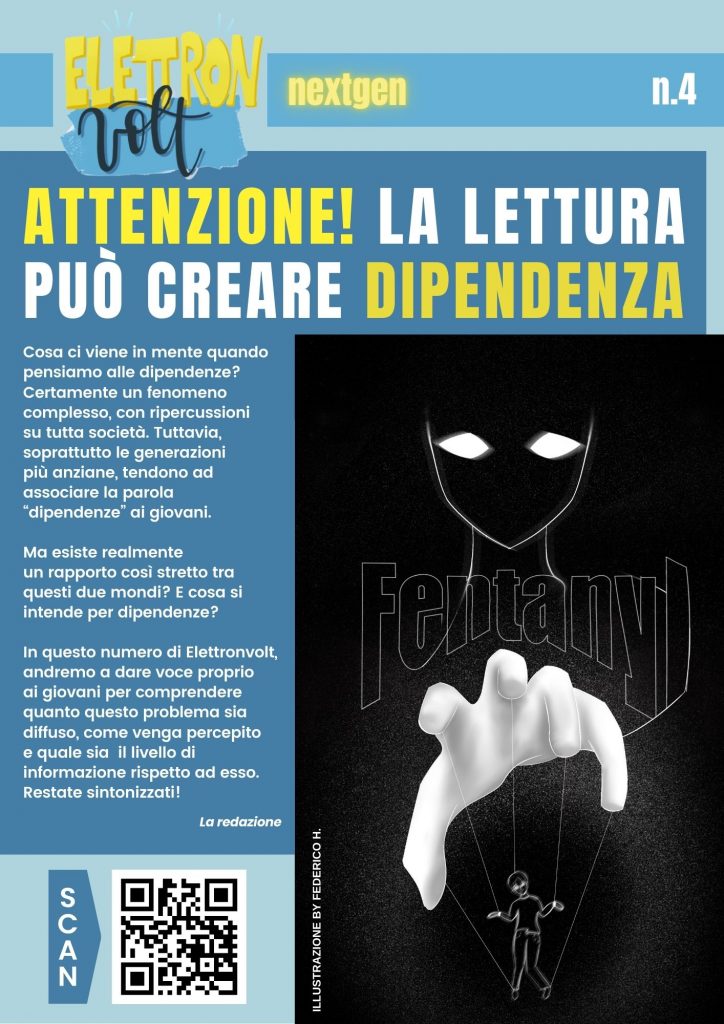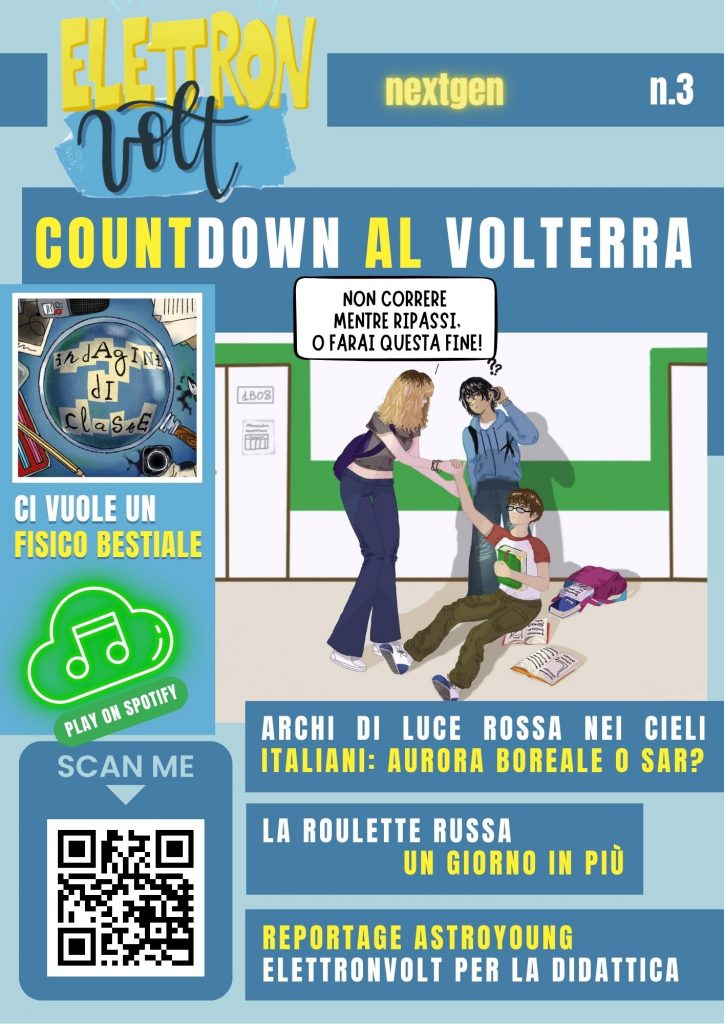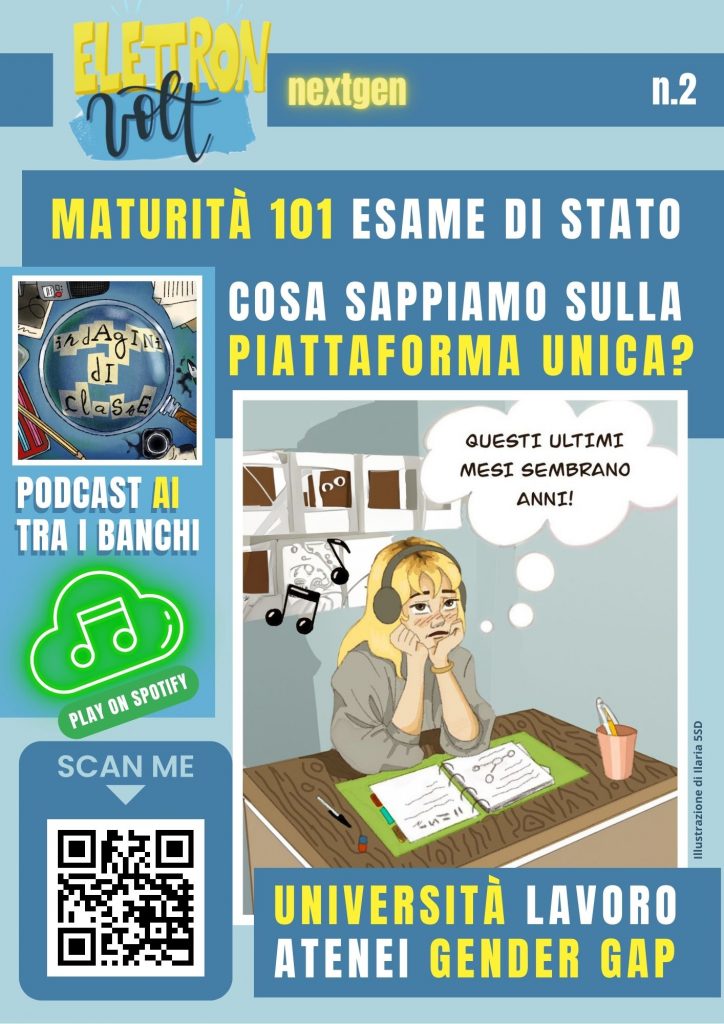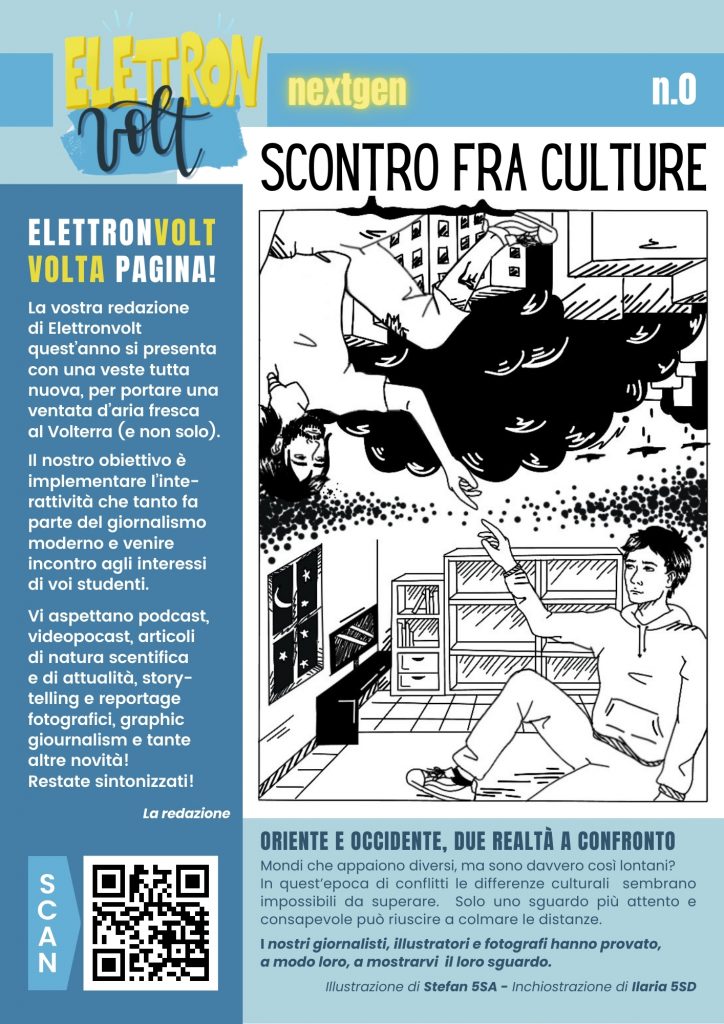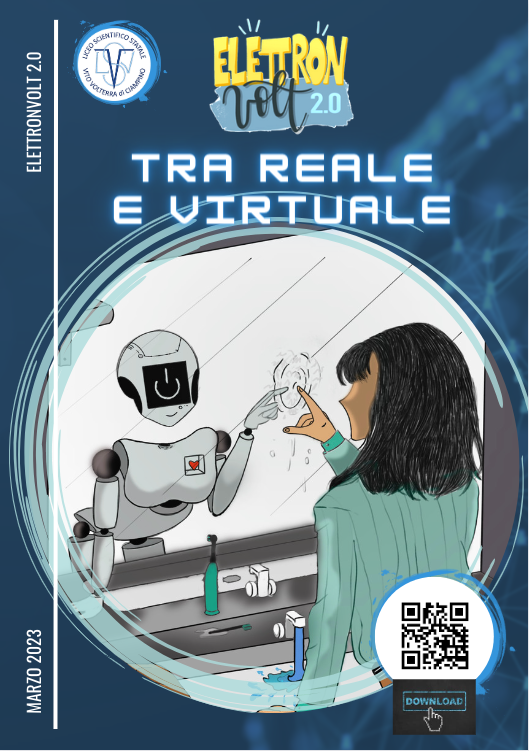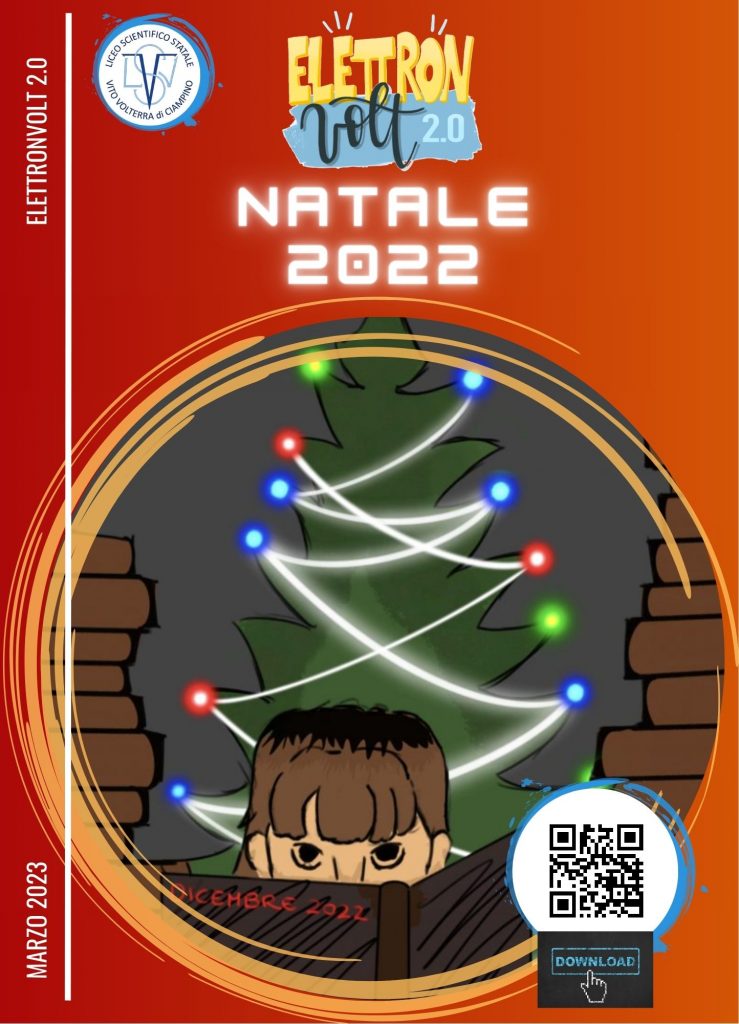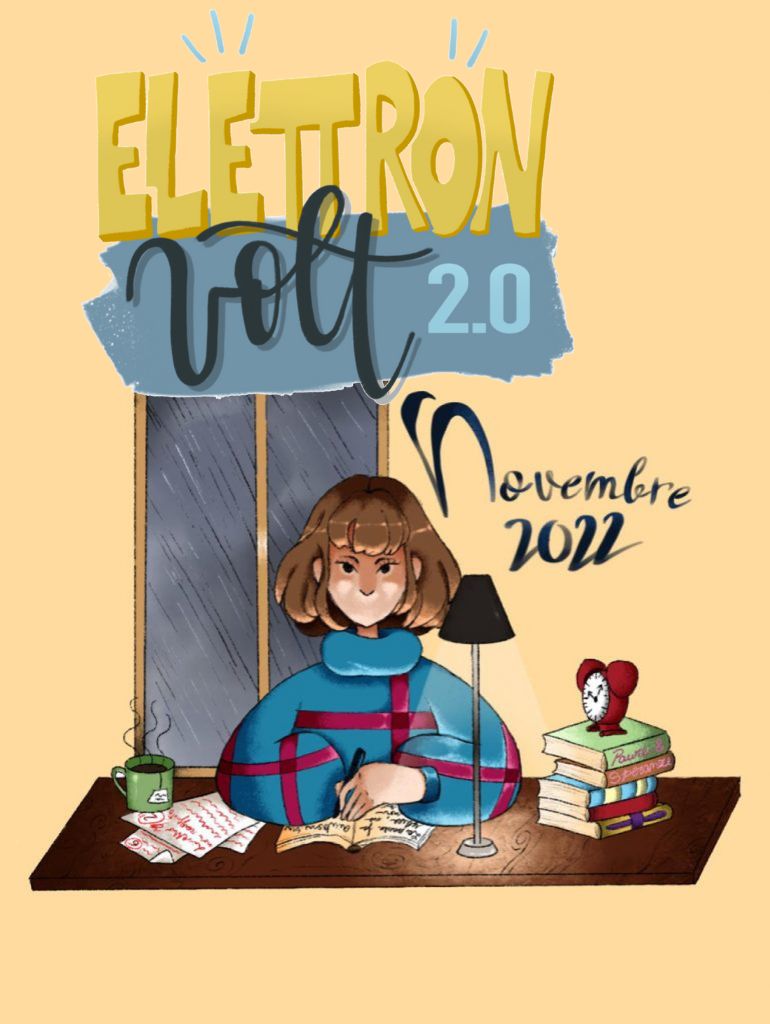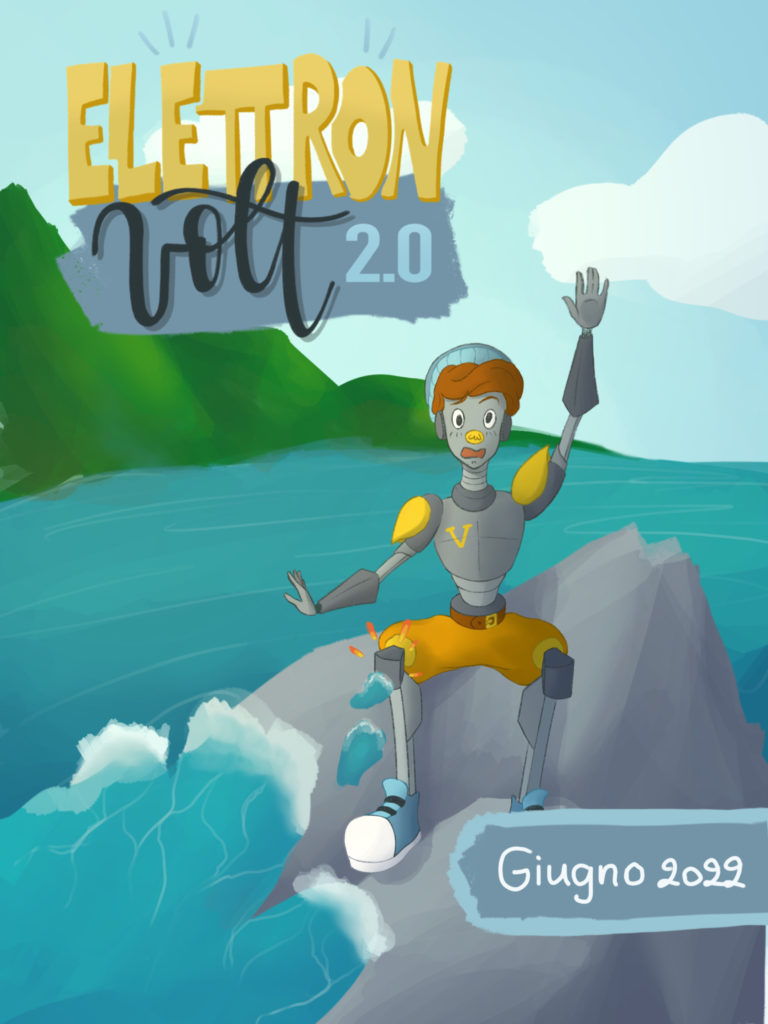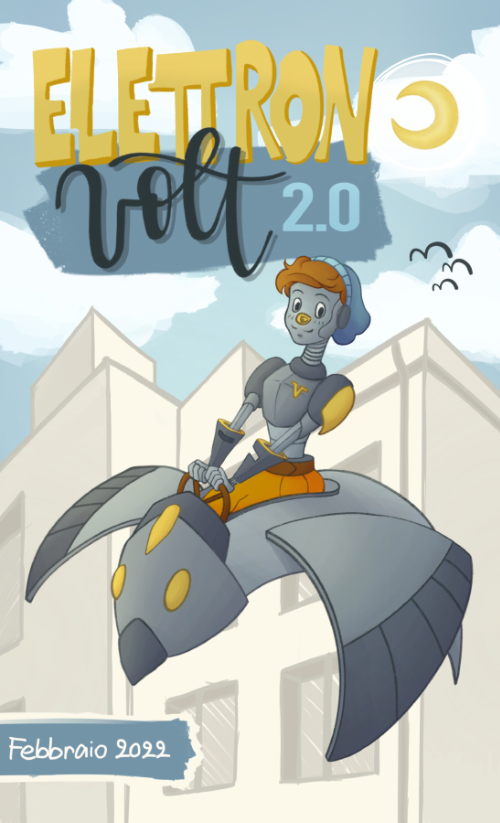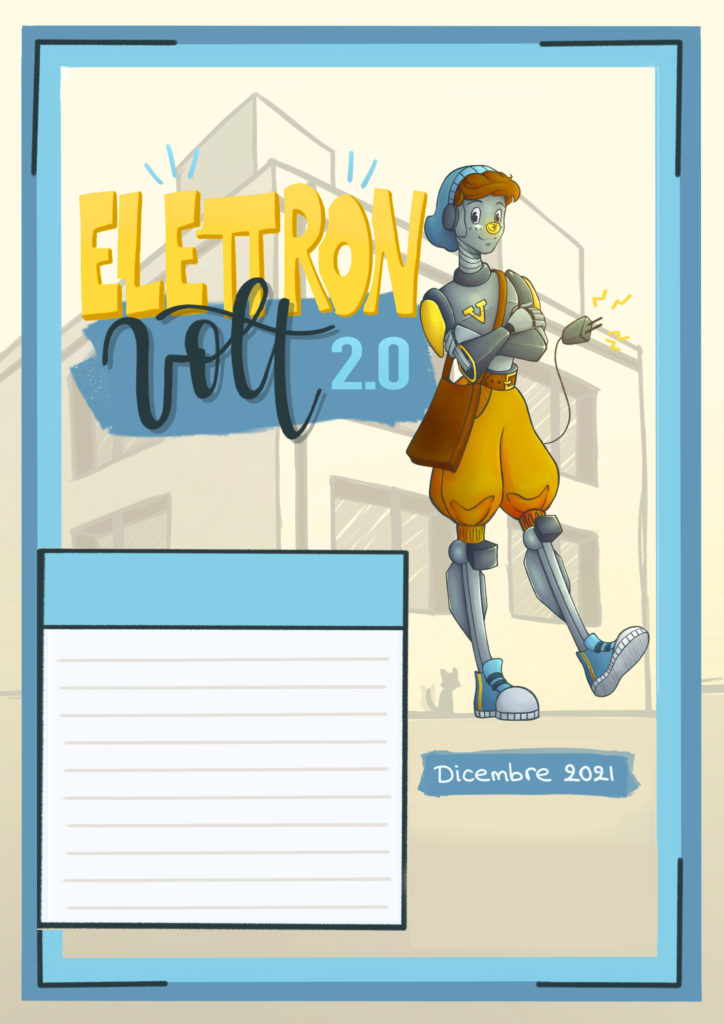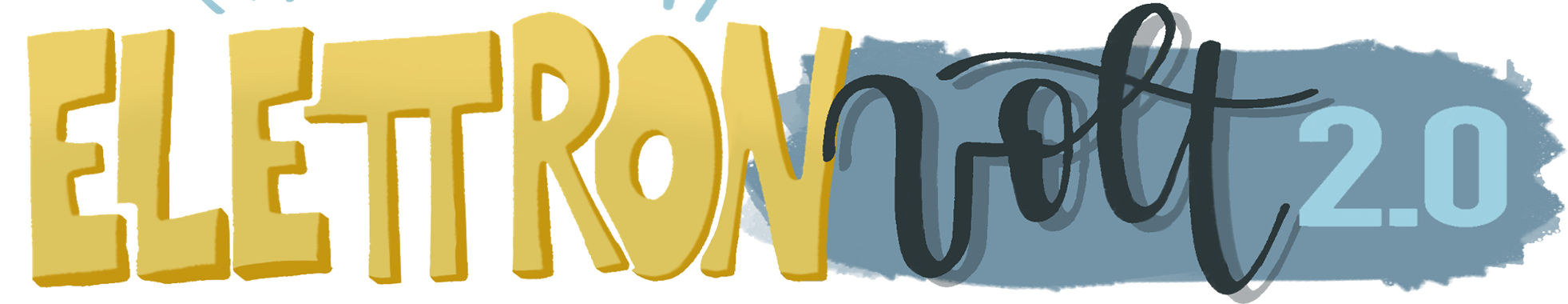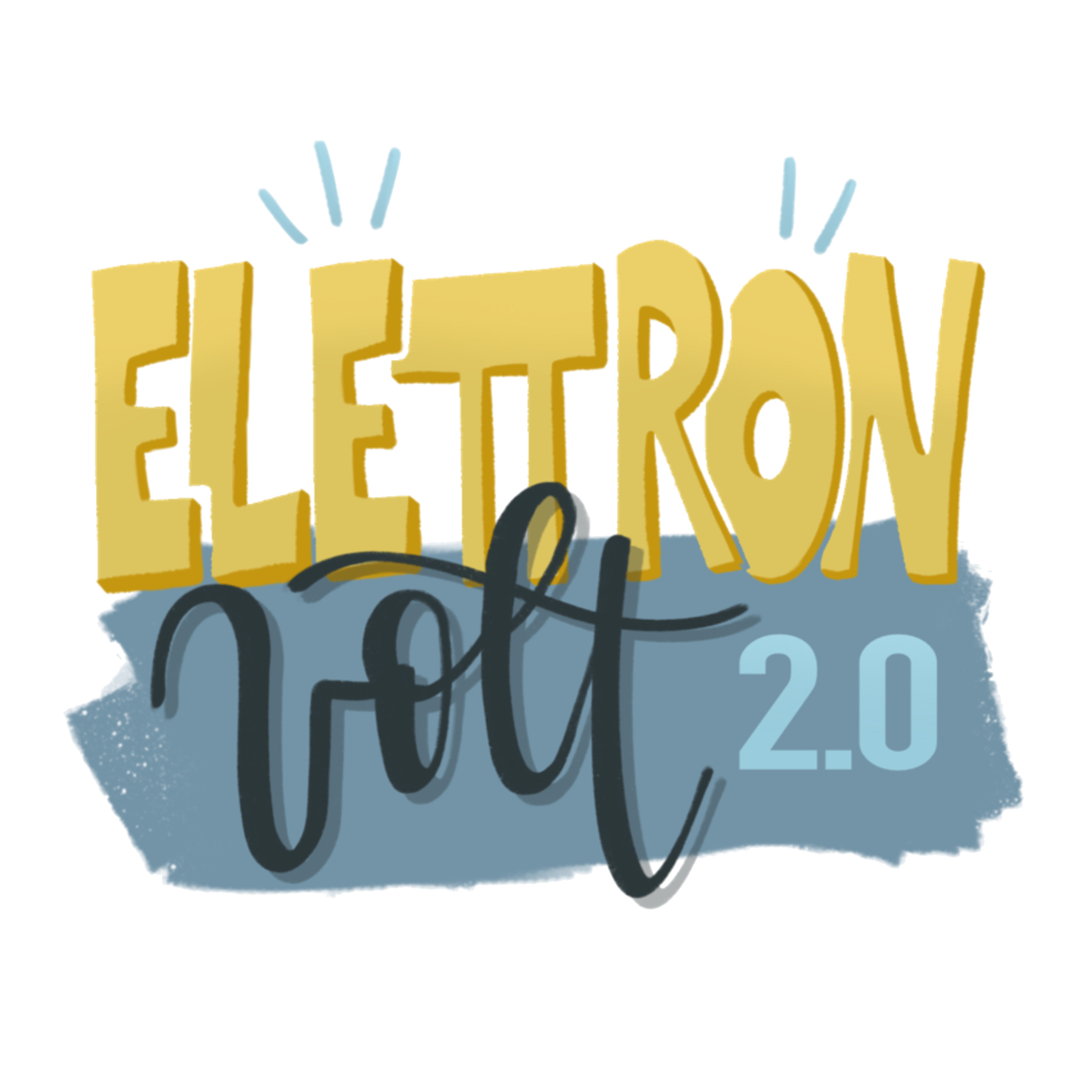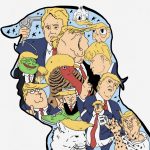L’antiscienza di Donald Trump nella visione del clima
Gli accordi climatici sono accordi internazionali, vincolanti da un punto di vista legislativo, che puntano ad una maggiore sostenibilità e consapevolezza dell’impatto dell’uomo sul clima. Ripercorrendo le principali tappe storiche sugli accordi climatici, occorre senz’altro menzionare i due principali e più famosi accordi climatici: il protocollo di Kyoto e l’accordo di Parigi.
Il protocollo di Kyoto, firmato nel 1997, fu il primo accordo internazionale a favore della riduzione dell’emissione dei gas serra, in occasione della Conferenza delle parti (COP 3).
L’accordo di Parigi, stipulato nel dicembre 2015, è un altro importante trattato che si focalizza sulla riduzione dei gas serra e sullo sviluppo sostenibile attraverso l’ormai nota Agenda 2030. Il trattato segue tre macrodirettrici: la mitigazione, l’adattamento e la finanza climatica.
Tale accordo è stato di recente sotto i riflettori dei mass media a causa della volontà dell’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, di uscire da tale accordo, avendo firmato un ordine esecutivo che avvia il processo di ritiro.
Le idee e visioni politiche emerse durante la sua presidenza hanno influenzato e influenzano fortemente la politica americana e internazionale. In modo particolare, le convinzioni di Donald Trump riguardo il clima e il cambiamento climatico sono caratterizzate da un forte scetticismo verso le politiche ambientali internazionali e da un’enfasi sulla promozione delle industrie di combustibili fossili. Ne risulta che i quattro anni del primo mandato di Donald Trump sono stati quattro anni di legittimazioni, sdoganamenti e tabù infranti, specie sulle questioni climatiche. Alla Casa Bianca è passato, così, il principio secondo il quale si può contestare la necessità di combattere i cambiamenti climatici, si può uscire dall’accordo di Parigi e si possono contestare tutte le prove che la comunità scientifica ha mostrato per decenni sul riscaldamento globale e sulla sua origine antropica.
Ripercorriamo le principali tappe durante il suo primo mandato che hanno portato a ciò. Inizialmente, nel non troppo lontano giugno 2017, il Presidente Trump ha annunciato la volontà di abbandonare l’accordo di Parigi, confermando le proprie posizioni risolutamente climatoscettiche; nello stesso anno ha annunciato la ripresa delle esplorazioni petrolifere nell’oceano Artico.
In seguito, durante il corso del 2018, Trump ha minacciato di alleggerire gli standard richiesti ai produttori americani in termini di emissioni di anidride carbonica. A settembre del 2019, il Presidente ha suscitato invece l’ira delle organizzazioni non governative ambientaliste di tutto il mondo stabilendo che su oltre 600000 ettari di pianure costiere dell’Alaska si sarebbe potuto procedere con attività estrattive di petrolio e gas. Nel febbraio dell’anno successivo, il 2020, in questa escalation di decisioni e conseguenti avvenimenti, il governo degli Stati Uniti ha reso operativi i piani di gestione di due riserve nazionali nello Utah: tali modifiche hanno consentito alle compagnie energetiche di avviare attività estrattive petrolifere e minerarie in un’area di quasi 350000 ettari.
Quattro anni dopo, conclusosi il mandato del Presidente Biden, si giunge al secondo mandato di Trump. In appena 24 ore dal suo nuovo insediamento, avvenuto il 20 gennaio 2025, il magnate ha firmato l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi per combattere il cambiamento climatico.
L’uscita richiede un anno dalla presentazione di una notifica formale al segretario delle Nazioni Unite, notifica già eseguita dalla Casa Bianca. Come ha confermato l’ONU, il ritiro definitivo degli USA dall’accordo di Parigi avverrà il 27 gennaio 2026. A quel punto gli Stati Uniti saranno ufficialmente fuori dall’accordo insieme all’Iran, alla LIbia e allo Yemen. Nel corso del periodo di tempo che intercorre tra la notifica dell’uscita e la sua entrata in vigore Trump deciderà se inviare o no delegazioni a riunioni sul clima. Nella nota del segretario generale Antònio Guterres si legge: “[…] è cruciale che gli Stati Uniti rimangano un leader sulle questioni ambientali”. Gli Stati Uniti, infatti, sono il secondo maggior produttore di gas serra: sono responsabili di circa il 13% delle emissioni di CO2 e l’uscita di Trump dall’accordo indebolirebbe, quindi, le trattative a livello internazionale e segnerebbe un grande passo indietro per quanto riguarda la lotta alla crisi climatica.
Lo Science Based Target è un insieme di obiettivi volti a ridurre le emissioni di gas climalteranti, specialmente quelle di anidride carbonica. Le basi di queste iniziative sono state stipulate nel settembre del 2015 dalle Nazioni Unite. Nel medesimo anno è stata poi formata la Science Based Target initiative, comunemente nota come SBTi, un’organizzazione che ha come compito quello di supportare le aziende nell’avviare pratiche più sostenibili, a riduzione delle emissioni.
Un forte sostegno a questa iniziativa era il fondo del Bezos Earth Fund, un’organizzazione filantropica per il contrasto al riscaldamento globale, che di recente è stato interrotto. Fonti vicine all’organizzazione di Bezos riferiscono che all’origine di tutto c’è la necessità di non alterare il presidente Trump, che sembra aver definito il cambiamento climatico una “bufala”. Per quanto ne riguarda, il presidente stesso ha dichiarato: “[…] non riesco ad immaginare qualcuno che, con qualcosa da perdere, voglia davvero esporsi sul cambiamento climatico negli Stati Uniti”.
E così lo slogan “drill, baby, drill” è così diventato un grido celebre da quando Trump fece il suo discorso di uscita dagli accordi. In italiano questo si traduce letteralmente in “perfora, piccola, perfora”. Con queste parole il Presidente ha espresso la volontà di sfruttare al massimo le risorse fossili di tutto il paese, ribaltando decenni di politiche ambientaliste e favorendo un’espansione nell’estrazione di combustibili fossili come il petrolio, il carbone e il gas naturale. Come è facile immaginare, questa idea non ha reali benefici, ma bisogna comunque considerare due vantaggi. In primis, grazie a questa nuova politica, Trump offrirà nuovi posti di lavoro nei settori che si occupano sia dell’estrazione delle sostanze e, in secundis, aumentare la produzione di combustibili fossili significherebbe abbassare i prezzi dell’energia e rendere dunque gli USA sicuramente meno dipendenti dai paesi fornitori esteri.
Al contrario, ciò che rende più impattante questo messaggio sono i problemi, e dunque i contro, che sollevano, tra gli ambientalisti e non solo, un grande dibattito. Se si perfora per estrarre sempre più gas e petrolio, il rischio di inquinamento aumenterà e si ritarderà la transizione energetica verso il rinnovabile. Al contempo si avrà un forte indebolimento della leadership americana sulla tematica del clima e ciò potrebbe causare un effetto domino da parte di altri stati internazionali (Brasile e Australia stanno già rallentando).
È chiaro, quindi, che se Donald Trump non cambia rotta, si potrebbero registrare conseguenze devastanti per tutto il mondo: gli Stati Uniti sono, infatti, tra le economie globali più forti e tra i Paesi con emissioni inquinanti più elevate, e la rinuncia agli accordi di Parigi da parte del Presidente potrebbe spingere anche altri paesi a fare lo stesso, o a demordere sugli impegni ecologici, rallentando il progresso globale.
Nonostante ciò, molti stati americani e aziende hanno deciso di continuare a combattere per la causa ambientale, e, insieme a loro, anche Europa, Cina e altre potenze globali hanno incrementato gli sforzi per la sostenibilità.